 In occasione dell’inaugurazione della Sala Billi presso il Centro Letterario del Lazio di Via Merulana, a Roma, dal 3 al 13 novembre 1987 si è tenuta la mostra “Momenti di luce oltre la luce”. La sala è stata dedicata ad Andrea Billi, poeta, scrittore e giornalista RAI.
In occasione dell’inaugurazione della Sala Billi presso il Centro Letterario del Lazio di Via Merulana, a Roma, dal 3 al 13 novembre 1987 si è tenuta la mostra “Momenti di luce oltre la luce”. La sala è stata dedicata ad Andrea Billi, poeta, scrittore e giornalista RAI.
Questa la presentazione della scrittrice e critica d’arte Maria Teresa Palitta, comparsa su SAFJ Press, Agenzia stampa settimanale d’informazione culturale: «Marina Sagramora, con eloquenza individuale, attraverso l’immagine consacra la dottrina esoterica relativa all’interiore a un’ascesi profonda che a tratti diviene catarsi per espandersi attraverso l’essenza, sconfinando dalla realtà fisica all’inviolabilità metafisica, che tuttavia consente agli occhi dello spirito un’indagine ardente che nobilita l’impulso vitale a livello biologico e lo rende in sincronia con la forza del pensiero: unico vero traguardo del genere umano e quindi ben accetto all’arte creativa, in quanto travaso di energie per un compito d’amore e per creare “momenti di luce oltre la luce” che possano appagare chiunque intenda consolidare se stesso in immersione d’eterno…».
«Il silenzio» ![]()
In occasione della Mostra, il professor Alfredo Cantone, scrittore, critico letterario, Ispettore ai Beni Culturali di Roma, ha presentato il suo libro Amor di Parigi, un libro sugli artisti attivi a Parigi negli anni Sessanta, nel quale ha dedicato alla pittrice un capitolo dal titolo “L’Arte senza confini. Al Boul-Mich con Marina”, riportato qui di seguito.
L’ARTE SENZA CONFINI
AL BOUL-MICH CON MARINA
Un settembre del 1960, chiaro, luminoso, dalle calde serate, in questa estate che indugia ancora tra i tavoli dei piccoli caffè del brulicante Boulevard St. Michel.
Seduti, gruppi di studenti, di intellettuali, residui di esistenzialisti vistosamente annoiati, che della noia d’esistere fanno tema di vivaci e interminabili discussioni, animano di folclore il quartiere latino.
Mi avvicino ai tavoli di un piccolo bistro d’angolo che accoglie solitamente giovani pittori di tutte le nazionalità.
Barbuti i più, esili e nervose le ragazze, intenti tutti a discutere sull’arte, l’album degli schizzi in una mano, la forchetta nell’altra a tagliare e a portare velocemente alla bocca, nella foga del discorso, un’omelette o una crocchetta di patate.
Sorseggiano, sentenziando, l’ultimo cappuccino che chiude il rapido pasto serale.
Ho un appuntamento con una giovane pittrice, Marina Sagramora, unica italiana del gruppo che qui si riunisce dopo le lezioni serali all’Accademia della Grande Chaumière.
Dopo una vaga presentazione agli amici, Marina mi fa posto accanto a lei, schiacciato, dall’altro lato, dalla massiccia presenza di un ragazzone yankee, con una folta barba rossiccia, che non spiccica una parola di francese ma si inserisce continuamente nella discussione con il suo americano cantato e roboante. Lo ascoltano con rispetto, anche se non pare che tutti lo capiscano.
Si scorrono albi da disegno l’un l’altro per l’approvazione o il vivace disappunto; si srotolano grossi fogli di carta grezza, fitti di appunti grafici.
Mi passano davanti disegni di corpi sfatti che anziane modelle offrono alla posa per l’ora serale di scuola di nudo.
Marina, commentando i lavori che mi porgono per una rapida occhiata, mi dà brevi cenni dei vari autori.
«Questo – mi dice porgendomi un foglio – è di Déchou, che ha scoperto l’efficacia plastica del cubo».
Guardo interessato quello che sembra un mucchio informe di massi squadrati sovrapposti, cercando di rintracciare in quello strano effetto una qualsiasi grazia muliebre.
«E questa è Josette – continua, sostituendo il foglio con altro denso di nuvole di vapore – qui c’è tutta la delicatezza dell’animo femminile. Josette usa così tanto il mignolo che dice di esserselo notevolmente assottigliato. Dopo ogni tratto di carboncino il dito toglie ogni segno netto e sfuma tutto in un indistinto ma efficace incontro di luce e d’ombra».
Guardo perplesso questi ectoplasmi fluttuanti fra le nuvole, che passo al mio vicino barbuto, il quale scuote la testa disapprovando. È simpatico, penso, e schietto.
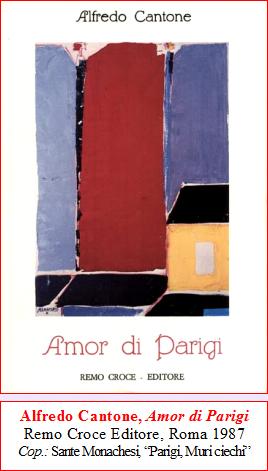 «Questo, invece, è di Tran Long – continua la ragazza, indicandomi un giovane dai piccoli occhi obliqui sorridenti e passandomi un rotolo di fogli coperti da sottili tratti di china.
«Questo, invece, è di Tran Long – continua la ragazza, indicandomi un giovane dai piccoli occhi obliqui sorridenti e passandomi un rotolo di fogli coperti da sottili tratti di china.
Osservo i disegni in cui si susseguono corpi levigati di fanciulle orientali dai lunghi capelli sciolti, le spalle appena scivolate, le labbra piccole e delicate, tentando di rintracciare, oltre la rielaborazione esotica, lo squallido originale delle vetuste modelle: potenza della creatività!
Chiedo a Marina di mostrarmi il suo album.
Il disegno è preciso, dettagliato, scolastico, con vistose correzioni fatte da altra mano.
Le chiedo chi l’aiuta nello studio e lei mi indica l’americano.
«È Raleigh Clay Wilkerson, un vero maestro per tutti noi. Ha studiato anatomia in maniera eccellente, anche se macabra: insieme ad altri studenti della scuola d’arte del suo paese, andava di notte in un cimitero isolato dove dissotterravano scheletri umani che venivano accuratamente sezionati e divisi equamente fra di loro. A casa disegnavano crani, femori, tibie, fino ad una perfetta conoscenza della struttura ossea e delle sue possibilità di articolazione nel corpo. Raleigh è un riferimento sicuro per ognuno di noi, più dello stesso maestro dell’accademia, interessato solo alla nostra interpretazione personale del modello.
Mi passano altri fogli, altri album.
«Questo è dell’irlandese Jacinta Murray, quella ragazzona rossa seduta vicino allo spilungone tedesco Werner Richter. S’incontrano con difficoltà sul piano linguistico, in un francese appena balbettato, ma su quello artistico e passionale s’intendono a perfezione».
Li guardo attentamente questi giovani, uno per uno, tesi al raggiungimento dell’Arte vera, quella con l’A maiuscola.
S’è fatto tardi. Marina si alza e con lei gli amici. Si salutano tutti con calore: «A demain».
In un angolo rimane la coppietta dall’incerto idioma. Lui e lei vicini, uniti da una matita che traccia sulla carta-tovaglia del tavolo il sogno che inseguono entrambi.
Chiedo a Marina dove abita e se posso accompagnarla.
Mi fa cenno di sì con un sorriso:
«Abito qui vicino, a Saint Germain des Prés, al Foyer “Maison des Etudiantes” di Rue Bonaparte. C’è ancora un po’ di tempo prima che chiudano la porta, all’una di notte. Chi supera quell’ora deve attendere la riapertura, alle sei del mattino. Mi è successo una volta di tardare per pochi minuti. Le luci erano spente all’interno. Era stata tolta anche la suoneria del portone».
«Come hai fatto? Hai passato la notte fuori?».
«Quella volta mi accompagnava un giovane artista nero del Mali, richiamato ora in patria dal padre. “In una neonata Repubblica come la nostra non c’è posto per i sognatori – gli aveva detto. – Bisogna costruire un nuovo Stato, lavorare, impegnarsi. L’arte verrà dopo”. Abbiamo passato quelle ore camminando per le strade deserte della Rive gauche, io decantandogli le bellezze dell’arte italiana, lui descrivendomi la sconfinata vastità della sua Africa, l’importanza di suo padre, capo tribù saggio e venerato, la gioconda opulenza carnale di sua madre, l’allegria spensierata dei suoi ventidue fratelli. E poi – con una malcelata nostalgia – il sapore fantastico della tenera carne di coccodrillo gustata in comunità durante le feste tribali. “Tutto questo finirà – mi diceva sospirando. – Verrà la civiltà, l’automazione presa a prestito da culture non nostre, e i nostri figli non sapranno più assaporare la vita patriarcale, dai ritmi lenti, che i nostri padri armonizzavano con la natura”. Quando mi ha riaccompagnata al Foyer, alle sei del mattino, mi sembrava di tornare da un lungo emozionante viaggio in terre lontane. È partito qualche giorno dopo, lasciando un grosso vuoto nel nostro gruppo».
Arrivati al portone con un discreto anticipo sulla chiusura, Marina mi chiede di attenderla un attimo in strada. Sale velocemente in camera e ne ridiscende con tre sue tele ad olio. Me le sottopone all’incerta luce d’un fanale. Due sono figure femminili ieratiche, di una sacralità trascendente, immerse in un paesaggio onirico. La terza è un globo di luce all’interno di un’ampia caverna. Bagliori alle pareti diradano il buio che preme attorno.
«È una pittura simbolica la mia. Fra gli “ismi” in voga non ho trovato quello adatto per me. Così me ne sono coniato uno da sola: il “trasfigurativo” – mi dice Marina, cercando di scoprire nei miei occhi il mio pensiero in proposito. – La rappresentazione classica o decorativa della realtà non mi è congeniale. Non seguo correnti. Sarà dura la mia strada, ma sarà mia. Sono certa che me la caverò».
La voce s’increspa appena nel forzare il tono alla determinazione e un lampo si accende nei suoi occhi chiari.
Guardo ancora il globo luminoso al centro della tela: è il simbolo della fiaccola che, in questo periodo, arde di magica speranza nel cuore di ogni artista qui a Parigi.
L’ho riveduta molto più tardi Marina, artista già affermata, a Roma, in una Galleria d’arte in via del Babuino ove, nel febbraio del 1986, esponeva una trentina di sue opere. Un noto critico d’arte così ne ha presentato lo stile: «Una pittura esoterica che va dalla liberazione dell’essenza alla contemplazione, per sfociare nella coscienza della luce».

